Quando qualcuno scivola su un marciapiede ghiacciato, di solito non si chiede perché il ghiaccio sia così insidioso. Si cerca l’equilibrio, si lanciano imprecazioni al suolo e si accelera il passo. La cosa curiosa è che, anche dopo secoli di scienza, la spiegazione che ci è stata insegnata a scuola su questo scivolone continua a ripetersi: il ghiaccio si scioglie a causa della pressione o del calore generato quando lo calpestiamo, e quel sottile strato d’acqua è ciò che ci fa scivolare. È davvero questa la spiegazione? Non è così chiaro. Questa vecchia idea è stata appena smontata. Un nuovo studio condotto dal fisico Martin Müser e pubblicato su Physical Review Letters dimostra che né la pressione né l’attrito sono i veri responsabili della pericolosità del ghiaccio. Ciò che ci fa scivolare ha invece a che fare con l’interazione elettrica tra le molecole. Si tratta di una spiegazione elegante, basata su simulazioni molecolari, che rivoluziona ciò che si sapeva sul comportamento del ghiaccio al contatto.
Il vecchio paradigma finalmente superato
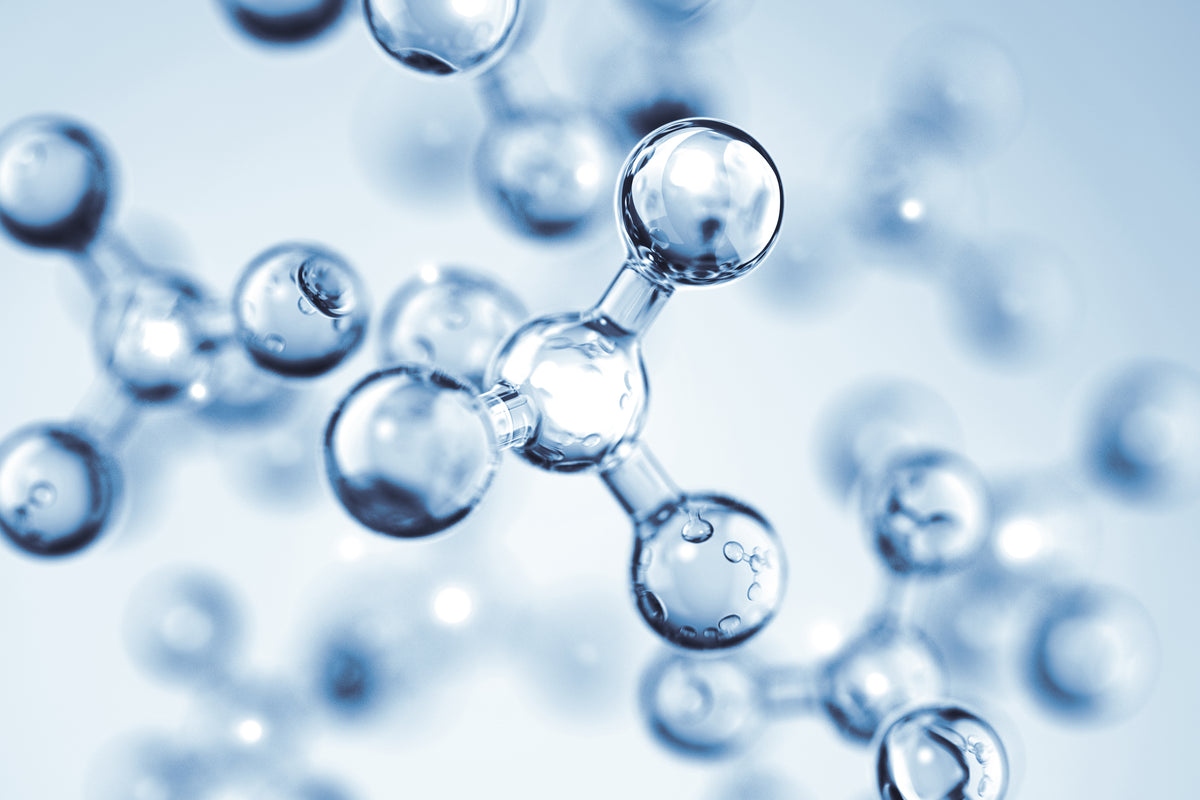
Per quasi due secoli, la teoria dominante sosteneva che l’attrito durante la camminata o il peso del corpo quando calpesta il ghiaccio generassero calore sufficiente a sciogliere un sottilissimo strato superficiale. Quest’acqua agiva come un lubrificante naturale, riducendo l’attrito e facilitando lo scivolamento. L’ipotesi era sostenuta da nomi illustri, come James Thompson, fratello di Lord Kelvin.
Ma il nuovo studio, condotto dai ricercatori dell’Università del Saarland, ha dimostrato che questa spiegazione è scientificamente insostenibile. Utilizzando simulazioni a livello molecolare, il team ha scoperto che il ghiaccio può diventare scivoloso senza bisogno di calore o pressione estrema, sfidando così il nucleo della teoria classica.
Secondo l’articolo, “le superfici ghiacciate si liquefanno senza fondersi termodinamicamente, ma prevalentemente attraverso un’amorficizzazione fredda indotta dallo spostamento”. Ciò implica che la struttura del ghiaccio si disordina localmente quando entra in contatto con un altro materiale, come la suola di una scarpa, a causa dell’interazione tra le cariche elettriche di entrambe le superfici.
Dipoli, disordine e superfici che si deformano senza sciogliersi
Per comprendere questo fenomeno, è essenziale sapere cos’è un dipolo molecolare. Si tratta di una molecola che ha una distribuzione di carica irregolare, ovvero un’estremità leggermente positiva e l’altra leggermente negativa. Nel caso dell’acqua ghiacciata, i dipoli delle molecole sono disposti in modo stabile in una rete cristallina.
Quando un altro materiale, come una scarpa o uno sci, entra in contatto con quella superficie, i dipoli del ghiaccio e dell’oggetto interagiscono. Ciò provoca una rottura dell’ordine, causando la disorganizzazione delle molecole e il loro passaggio a uno stato amorfo. Non è ghiaccio solido, ma non è nemmeno acqua liquida nel senso convenzionale. È uno stato intermedio che si comporta come uno strato lubrificante ultrasottile.
Il team lo spiega così: “L’interfaccia ghiaccio-ghiaccio più liscia possibile, incommensurabile, forma siti freddi saldati localmente, dove lo spostamento laterale innesca un’amorficizzazione senza calore o grandi pressioni normali”. Questa amorficizzazione, ovvero la perdita dell’ordine cristallino, avviene senza che il ghiaccio raggiunga il suo punto di fusione.
Che cos’è l’amorficizzazione?

L’amorficizzazione è il processo attraverso il quale un materiale perde la sua struttura cristallina ordinata e si trasforma in una forma disorganizzata, nota come stato amorfo. Nel caso del ghiaccio, ciò significa che le molecole d’acqua smettono di essere allineate in modo regolare, come in un cristallo, e passano a uno stato caotico, senza uno schema definito. Questa trasformazione non implica che il ghiaccio si sciolga in acqua liquida, ma che assume una forma intermedia che agisce come uno strato lubrificante sulla superficie.
Il mito che non si possa sciare a -40 °C
Una delle credenze più radicate, anche tra gli sciatori professionisti, è che al di sotto dei -40 °C non si possa sciare perché non si forma lo strato d’acqua necessario per scivolare. Questo lavoro dimostra che anche questo è sbagliato. Sebbene in queste condizioni estreme lo strato liquido sia più viscoso — “più denso del miele”, come lo descrivono gli autori nella loro nota divulgativa —, continua a esistere.
Ciò che è rilevante è che questo sottile strato non deriva dallo scioglimento, ma dal disordine strutturale indotto dal movimento. Anche a temperature vicine allo zero assoluto, le interazioni dipolari rimangono attive e lo strato lubrificante si forma comunque.
Questa scoperta cambia l’approccio alla comprensione dello scivolamento sul ghiaccio in condizioni estreme. Non si tratta di quanta acqua si genera con il riscaldamento, ma di come si riorganizzano le molecole del ghiaccio quando viene applicata una forza, per quanto lieve.
Il ruolo del materiale a contatto: non tutto scivola allo stesso modo
Un’altra importante scoperta dello studio è che il tipo di materiale che entra in contatto con il ghiaccio influenza notevolmente il livello di attrito. Le simulazioni hanno dimostrato che le superfici idrofobiche, quelle che respingono l’acqua, generano meno attrito rispetto a quelle idrofile.
Ciò accade perché la struttura dell’acqua amorfa viene alterata meno quando è a contatto con materiali che non la attraggono. Di conseguenza, lo strato lubrificante rimane stabile più a lungo, favorendo uno scivolamento più efficiente. Nelle parole degli autori: “Oltre all’acqua interfacciale, le controparti devono essere lisce e idrofobiche affinché il ghiaccio abbia coefficienti di attrito molto bassi”.
Questa scoperta ha applicazioni dirette nella progettazione di pneumatici, calzature antiscivolo e attrezzature sportive. Se è possibile manipolare l’attrito attraverso il materiale, è possibile sviluppare tecnologie che riducano significativamente il rischio di cadute o aumentino le prestazioni nello sport.
Non è il calore, è lo spostamento
Forse uno degli aspetti più controintuitivi di questo lavoro è che il ghiaccio diventa più scivoloso quanto più è freddo. A -10 °C, ad esempio, il ghiaccio amorfo presenta una viscosità maggiore rispetto a temperature più basse. Ma questo non significa che ci sia più attrito. Infatti, il tasso di amorfizzazione, il processo che genera quello strato scivoloso, è maggiore quando il ghiaccio è più freddo.
Ciò contraddice direttamente l’idea che il calore sia necessario per sciogliere il ghiaccio e facilitarne lo scivolamento. Lo studio confronta il comportamento del ghiaccio a -10 °C e a 10 K (circa -263 °C) e rileva che “i cristalli di ghiaccio più freddi si amorfizzano più rapidamente”.
La spiegazione sta nella meccanica molecolare. A tali temperature, le molecole sono così rigide che, quando viene applicata una forza, non hanno il tempo di riorganizzarsi e semplicemente si disordinano, formando quello strato che permette lo scivolamento.
Una rivoluzione silenziosa con applicazioni molto concrete

Sebbene questa scoperta possa sembrare teorica, ha implicazioni dirette in molti ambiti della vita quotidiana e della tecnologia. Dalla progettazione di pneumatici per strade ghiacciate alla produzione di sci o allo sviluppo di materiali antifrizione, comprendere il vero meccanismo dello scivolamento sul ghiaccio permette di prendere decisioni basate sulla fisica reale, non su supposizioni ereditate dal XIX secolo.
Invita anche a rivedere il modo in cui viene insegnata la fisica del ghiaccio nei livelli di istruzione di base. Le nuove prove dimostrano che il fenomeno non dipende principalmente dal calore o dalla pressione, ma da effetti strutturali ed elettrici a livello microscopico, che possono essere modellati con moderni strumenti di simulazione.
Infine, questo progresso dimostra il valore della scienza di base. Quella che era iniziata come una curiosità sul perché il ghiaccio è scivoloso ha finito per cambiare la nostra comprensione di un fenomeno quotidiano. E lo ha fatto con uno strumento invisibile ma potente: la simulazione al computer a livello atomico.









